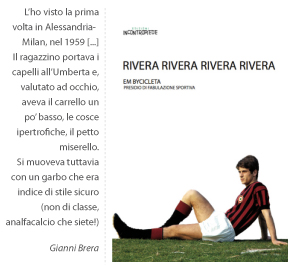Il livello tecnico e agonistico di questo campionato europeo di calcio è alto.
Francia, Belgio, Portogallo e Inghilterra, sembrano essere di un livello superiore a tutte le altre, ma ogni squadra ha mostrato di avere campioni in grado di risolvere, anche da soli, ogni partita.
Un discorso a parte merita l’Italia di Roberto Mancini.
Il percorso compiuto dagli azzurri fino ad oggi è straordinario. Dieci vittorie su dieci nella fase di qualificazione all’Europeo e due su due, entrambe per 3-0, in questo inizio di torneo. La squadra è imbattuta da 29 partite, dal 10 ottobre 2018 e non subisce gol da dieci partite, dal 14 ottobre 2020.
Eppure, in molti continuano ad esprimere perplessità, a sostenere che sia una squadra senza stelle di prima grandezza, che le manchi il campione assoluto.
Innanzitutto, la prima stella della squadra è Roberto Mancini, un allenatore sottovalutato in relazione a ciò che ha vinto fino ad oggi.
In Italia tre campionati e quattro volte la Coppa Italia, record che detiene a pari merito con Sven-Göran Eriksson e Massimiliano Allegri, due volte la Supercoppa italiana. In Inghilterra, una volta la Premier League e poi una FA Cup e una Community Shield. Infine, in Turchia una Coppa nazionale.
Se invece analizziamo la rosa della squadra italiana, mi chiedo e vi chiedo: Donnarumma, Lorenzo Insigne e Jorginho sono inferiori ai campioni delle altre squadre?
E ancora Marco Verratti, Ciro Immobile, Nicolò Barella, valgono meno di chi gioca nei loro ruoli nelle altre nazionali?
E ancora Domenico Berardi e Manuel Locatelli è facile trovarli in altre nazionali?
La partita contro la Svizzera ha messo in mostra proprio questi due gioielli che solo chi non mastica calcio quotidianamente non conosceva.
Berardi è nato nel 1994, compirà 27 anni il 1° agosto. Ha esordito in serie A quando aveva 19 anni e fino ad oggi ha disputato 275 partite segnando 97 reti. Non è una scoperta, è una certezza.
Manuel Locatelli è nato nel 1998 ed ha 23 anni. Ha disputato 144 partite in serie A, realizzando 8 reti. Anche in questo caso non è una scoperta, ma una certezza.
Entrambi hanno disputato le ultime stagione al Sassuolo sotto la guida di Roberto De Zerbi, 42 anni e 254 panchine fino ad oggi. 22 in serie D, 77 in Lega Pro e 114 in serie A. Anche in questo caso non una scoperta, ma uno dei migliori allenatori italiani.
Il primo gol realizzato dall’Italia contro la Svizzera è un concentrato di questa storia e racconta, in parte, questi numeri.
Locatelli riceve la palla nella metà campo dell’Italia, poco oltre il cerchio di centrocampo e, d’istinto, con un lancio di 40 metri, al volo e senza far toccare la palla a terra, serve Berardi posizionato con i piedi quasi sulla linea del fallo laterale. Berardi controlla e porta a spasso un avversario che non riesce a contrastarlo e si avvia verso la linea di fondo. Locatelli dopo il passaggio si lancia verso l’area di rigore avversaria con una falcata che ricorda il giovane Marco Tardelli. Berardi, arrivato sul fondo, alza leggermente la testa e vede il suo compagno libero al centro dell’area piccola. Passaggio rasoterra, irrompe Locatelli ed è gol. Italia 1, Svizzera 0.
Un modo di ragionare e di pensare il calcio non casuale.
Certo non si può insegnare ad un calciatore come fare un lancio di 40 metri al volo per servire un compagno, per quello occorre avere del talento naturale. Quello che si può insegnare e che De Zerbi prima e Mancini poi hanno insegnato a questi due gioielli di calciatori, è pensare il calcio come opportunità per cercare sempre la via del gol. Si possono insegnare i movimenti.
Locatelli sapeva che Berardi era posizionato in quel posto. Lo sapeva perché succede nel Sassuolo, e succede, anche, nella nazionale italiana. Il posto di Berardi è quello e lui era lì. Dopo il lancio è scattato in avanti per chiudere l’azione, sapeva che Berardi avrebbe cercato il fondo campo e rimandato la palla indietro, perché succede nel Sassuolo e succede nella nazionale italiana.
Così è stato. Niente di casuale, un modo di ragionare e di pensare il calcio.
Siamo ancora convinti che la nazionale italiana non abbia stelle in squadra?
E allora Roberto Mancini, Domenico Berardi e Manuel Locatelli, cosa sono?
Non si costruisce bel calcio senza campioni e, soprattutto, non si vincono tante partite senza calciatori eccelsi. Anche per questa ragione è sbagliato affermare che la squadra italiana non ha campioni.
Roberto Mancini ha scelto e costruito una squadra con calciatori tecnici. Una squadra che cerca il gol attraverso il bel gioco. Un calcio armonico, europeo, che sfrutta tutta l’ampiezza del campo, ma che non disdegna attaccare la profondità per linee verticali. Un calcio che si costruisce con un possesso palla mai fine a se stesso, ma che cerca, in ogni zona del campo in cui si sviluppa, la strada più breve per arrivare al gol. Per arrivare all’essenza stessa del gioco del calcio.
È bello vedere come le catene che si sviluppano per linee esterne seguano sempre un filo logico. Quando, in fase di possesso palla, Zappacosta avanza sul lato sinistro, Lorenzo Insigne si preoccupa di coprire la porzione di campo che resta sguarnita e viceversa.
È bello vedere le incursioni di Barella e Locatelli che accompagnano sempre l’azione quando si sviluppa per linee verticali.
È bello vedere Ciro Immobile attaccare lo spazio e dettare il tempo del lancio a Jorginho o a Lorenzo Insigne.
È bello vedere, infine, lo spirito di squadra che l’allenatore e il suo gruppo di lavoro hanno saputo creare. È bello vederli sorridere, abbracciarsi. Gioire insieme. È bello vedere e riconoscere la spensieratezza della gioventù.
Il viaggio è iniziato e, come abbiamo imparato da Ulisse in poi, ciò che conta non è la meta ma il viaggiare stesso. E il viaggio della nazionale italiana di Roberto Mancini, appena iniziato, è già un gran bel viaggiare.